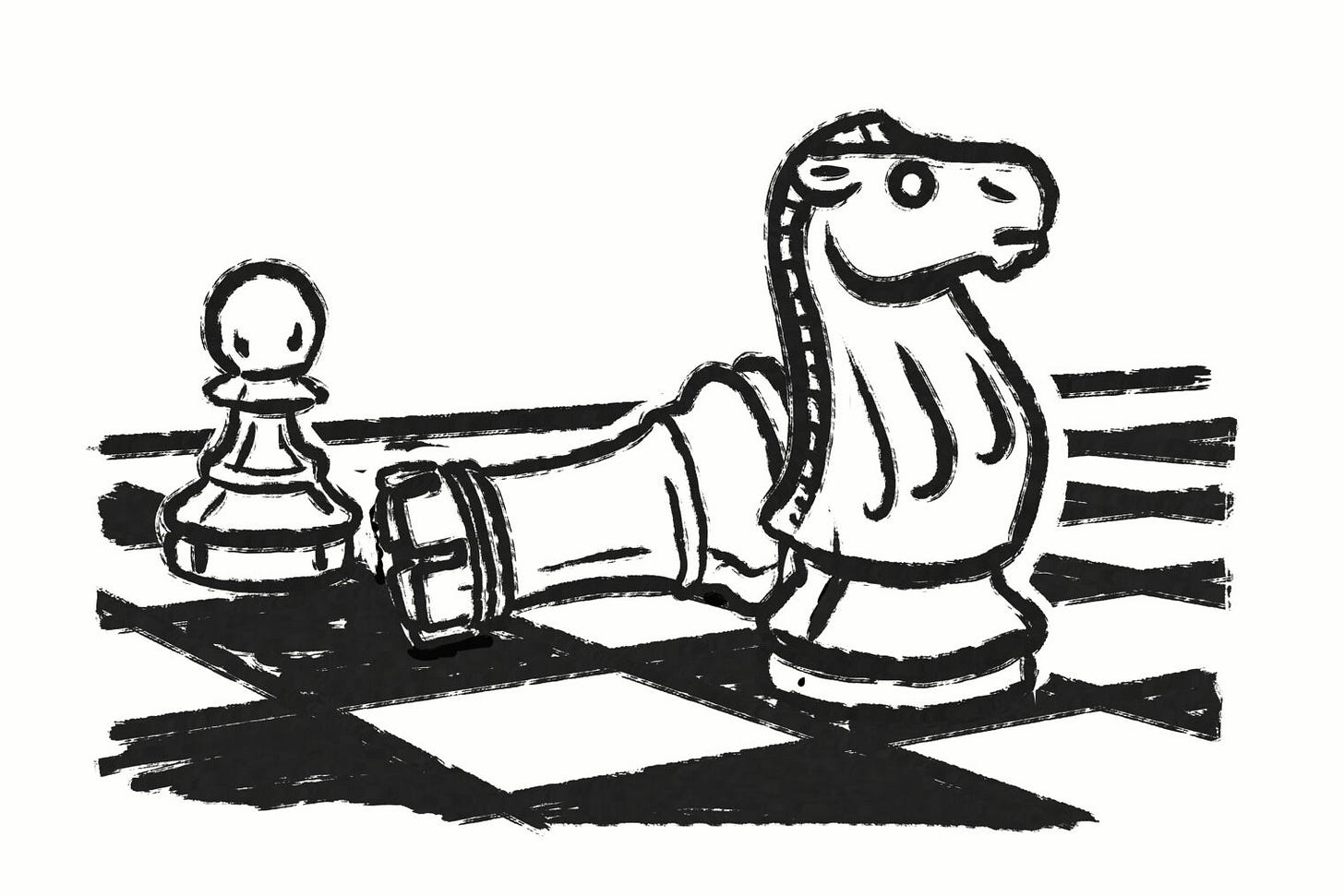Dieci tesi sul conflitto israelo-palestinese e la sua perduranza
Claudio Vercelli
storico
1) È del tutto inutile continuare ad usare le categorie novecentesche per comprendere le dinamiche, come anche le evoluzioni, nonché le evidenti involuzioni, del conflitto tra israeliani e palestinesi. Semmai, bisogna ripartire dal riscontro che quel confronto, il quale attraversa da sé ben due secoli, è come una sorta di cartina di tornasole del combinato disposto tra contrapposizione di comunità, conflitto civile, guerra ibrida e fibrillazione permanente delle singole società. In quanto tale, è al pari di una carta assorbente dei mutamenti, non solo in campo israeliano e palestinese, bensì di molte altre realtà. Recepisce, al medesimo tempo, la dolente consapevolezza di ferite non suturate e di irrisolte ostilità di principio. A partire da quelle postcoloniali. Non di meno, ci dice altro ancora. Se fosse altrimenti, invece, nessuno se ne interesserebbe per davvero, ossia quanto meno fino in fondo, arrivando ad oggi.
2) Il teatro mediatico, poste tali premesse, è una parte imprescindibile del conflitto medesimo, almeno dalla guerra del ’67 in poi. Quindi, a fare la differenza, in quel di Gaza, non è necessariamente l’assenza obbligata di corrispondenti dal campo, quelli per parte non palestinese. Ciò che invece interviene, con ossessiva ripetitività, è il rimando a immagini di circostanza, tali poiché reiteratamente ripetute. Sempre ed ovunque. Tra le quali: i bambini e le donne palestinesi che chiedono ostentatamente cibo; i miliziani di Hamas che riescono a controllare ancora parti della Striscia di Gaza (o simulano di potere fare ciò); Israele ricondotto al suo esercito, dai più inteso, ad oggi, come non solo una forza armata di occupazione bensì al pari di qualcosa di «nazista» (la ormai famosa «reductio ad hitlerum» di Leo Strauss; al tal guisa, credo che ci si dovrebbe scrivere un lungo trattato). Le guerre, dal Vietnam in poi, sono in fondo non solo proiettili a ripetizione ma anche fotogrammi in successione.
Leggi
Come definire l’antisemitismo?
Sergio Della Pergola
Università Ebraica Gerusalemme
Leggo su ViveVoci l’interessante intervento di Manuel Disegni “Definire l’antisemitismo” e vorrei proporre un approccio diverso.
Non entro qui nella discussione dettagliata delle definizioni proposte dall’IHRA, dal Gruppo del JDA, o dal gruppo Nexus, che ho svolto altrove (Sergio Della Pergola, “How best to define antisemitism: A structural approach?” Antisemitism Studies, 8, 1, 2024, 4-42). Noterei solamente che la definizione IHRA ha molti pregi ma anche alcune riconoscibili debolezze, di cui parlo in seguito. Ma la proposta alternativa JDA, che non si limita a definire cos’è l’antisemtismo ma anche che cosa non è antisemitismo, non solo incorre nelle stesse debolezze, ma è anche viziata da gravi contraddizioni, e propone certe formulazioni, cui accenno più avanti, che si possono paradossalmente classificare come antisemite. Pure la definizione Nexus pecca nel non capire quali siano, in definitiva, le richieste non negoziabili – le invalicabili linee rosse – da parte dell’ebreo, e quindi i limiti non tollerabili della diffamazione e della prevaricazione. Nessuno, in realtà, ha il diritto di impormi che cosa pensare, e soprattutto che cosa non pensare.
Definire l’antisemitismo
È la destra israeliana che strumentalizza l’accusa di antisemitismo per mettere a tacere chi critica le sue malefatte, oppure sono gli antisemiti che strumentalizzano la critica a Israele per veicolare odio contro gli ebrei? Sembra che nessun contendente voglia contemplare la possibilità che siano vere entrambe le opzioni.
L’intero dibattito sulla definizione dell’antisemitismo vorrebbe stare a cavallo fra la scienza e la politica, ma finisce per fallire su entrambi i fronti. Se l’obiettivo è fare dell’antisemitismo un oggetto di conoscenza scientifica, sostituire il lavoro del concetto e la ricerca storica con l’arbitrio definitorio non frutterà comunque risultati soddisfacenti.
Manuel Disegni
Università di Torino
Il concetto di antisemitismo è relativamente recente. Fu coniato da un giornalista tedesco verso la fine del XIX secolo, tale Wilhelm Marr, anarchico e antisemita egli stesso. La cosa, invece, ha più di duemila anni. Curioso il caso di un neologismo introdotto per designare una cosa che esiste ed è nota ai più già da tempo immemorabile.
Di che cosa parliamo noi oggi quando parliamo – adeguandoci, spesso ignari, al suo proprio lessico – di “antisemitismo”?
Nel corso del tempo, questa cosa si è manifestata in contesti sociali e spirituali tanto diversi; ha sviluppato un repertorio tanto vario e fantasioso di leggende, superstizioni e calunnie; ha assunto forme, metodi, motivazioni, ideologie, colori politici, perfino nomi tanto diversi; si è dimostrata tanto dinamica e tanto capace di adattamento – da suscitare l’impressione di essere non solo difficile, ma addirittura impossibile a definirsi.
Come si scrive la storia ebraica? La storia degli ebrei alla luce della storia cristiana
Come si scrive la storia ebraica? La storia degli ebrei alla luce della storia cristiana. Lo storico italiano Giacomo Todeschini ha portato a un prestigioso incontro dell’Università di Losanna lo studio che il lettore trova qui di seguito nella forma schematica di appunti, assieme alla sua versione originale in francese. Un testo non facile, ma che è importante diffondere anche al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori. Un testo che davvero vale la pena di affrontare.
Scrivere la storia ebraica da un punto di vista ebraico comunque subordinato alla cultura dominante ottocentesca e a maggior ragione dalla prospettiva della storiografia cristiana, comporta pesanti e pericolose distorsioni che si diramano fino ai nostri giorni. E la riduzione della storia degli ebrei alla storia dell’antisemitismo continua a rivelarsi un nuovo aspetto della prospettiva teologica di vedere il popolo ebraico. Il desiderio di raccontare, con molti dettagli, la storia di una distruzione e di un massacro funziona ovviamente come strategia retorica che ripropone la possibilità di unificare le storie degli ebrei, riunendole nel mito solo apparentemente filoebraico dell’univocità atemporale della storia della persecuzione. Questa mitologia della sofferenza si presenta come una vera e propria cancellazione della pluralità vivente delle storie che il popolo ebraico è stato capace di esprimere.
Giacomo Todeschini
storico
Una storia ebraica capace di reagire a una serie di rappresentazioni cristiane perfettamente teologiche prodotte a partire dall’epoca patristica, e dall’altro capace di produrre un racconto del passato degli ebrei di derivazione hegeliana.
Così come viene presentata da Heinrich Graetz nella sua Konstruktion der Jüdischen Geschichte, e poi nella sua Geschichte des Jüdischen Volkes, la storia ebraica derivata dalle rappresentazioni teologiche cristiane, proponeva anche una visione ispirata a Hegel, basata sull’idea, come ha notato Hans Liebeschütz, secondo cui la presenza ebraica nella storia rappresenta la realizzazione nel mondo di un destino in sé strettamente dipendente dal martirio determinato dalla prevalenza storica del Cristianesimo come potenza politica.
Allo stesso tempo, nella prospettiva di Graetz, il Cristianesimo poteva risultare come una forma deviata di giudaismo, come un tradimento storico all’interno di uno sviluppo storico la cui sostanza era unica.
Leggi
Israele e l’asino del nemico
Massimo Giuliani
Università di Trento
Un amico di lunga data mi sollecita via Whatsapp a scrivere su quel che sta succedendo a Gaza e mi suggerisce addirittura il titolo “Quale Israele?”. Mai titolo mi è parso più sbagliato. Mi sottraggo al facile paternalismo di dare giudizi su Israele, di qua gli ebrei buoni e di là gli ebrei cattivi. Mi sottraggo al gioco di citare recenti documenti ebraici per colpire Israele (come ha fatto di recente un vescovo sulla prima pagina di un quotidiano). Mi sottraggo persino dal tratteggiare l’Israele che mi piace (perché corrisponde alla mia visione politica del mondo) e contrapporlo all’Israele che non mi piace (appunto, perché va contro quel che io penso siano i valori che la società e lo stato di Israele dovrebbero incarnare). Per fare ciò dovrei “posizionarmi” e scendere nell’agone storico le cui proporzioni oggi mi sfuggono, tanto grave è la situazione. Negli ultimi sei mesi mi sono autoimposto il silenzio – ho messo una mano alla mia bocca – non perché non avessi da dire, ma per non prestare il fianco a chi odia Israele, ai suoi nemici (pochi ma spietati) e ai suoi antipatizzanti (che sono legioni in continua crescita), perché voglio essere solidare all’Israele reale e agli amici che vivono ad Haifa, a Gerusalemme… (la cui angoscia condivido al telefono ogni settimana); perché amo il popolo ebraico per quello che è, non per quello che vorrei che fosse; perché ho scelto di pregare di shabbat con quegli ebrei vivi e pensanti che, a differenza della stragrande maggioranza dei non ebrei, leggono davvero la Bibbia, la Torà, in ebraico (pur con traduzione italiana a fronte) e sanno dire: “La parashà di questa settimana è dura! Quale testo sacro è più esigente del nostro?”.
Leggi
Primo Levi e le curae chymicorum
Alberto Cavaglion
Università di Firenze
Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, […] devo dirgli, spiegargli del Medioevo, […] e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui.
Siamo al termine del capitolo “Il canto di Ulisse”, di fronte al passo più controverso e oscuro di Se questo è un uomo. Sono quasi arrivati alla meta, Primo e Pikolo. Volge al termine lo smisurato sforzo di rendere in francese i versi danteschi ripercorsi a memoria durante il percorso.
«Qualcosa di gigantesco»? Perché tanta urgenza, tanta necessità? Molti interpreti hanno pensato che «l’intuizione di un attimo», che sfiora Levi in quell’istante, rimandi a una dimensione biblica, sorprendente in Levi, ma plausibile data la solennità del contesto.
Le storie dei deportati essendo «storie di una nuova Bibbia», autorizzano una spiegazione provvidenzialistica di questo brano? Molti, a cominciare dal sottoscritto, si sono mossi per anni in questa direzione.
Eppure, in una nota al testo, di venticinque anni posteriore, redatta per l’edizione scolastica di Se questo è un uomo, Levi commentava il brano in modo diverso.
Vi sarebbe in queste righe – spiega – una «conturbante analogia tra il naufragio di Ulisse e il destino dei prigionieri», che percepiscono di essere perseguitati in quanto eredi di quella «“acutezza” intellettuale dell’ebraismo europeo», che i nazisti odiavano fino a farne uno degli argomenti-chiave della loro propaganda.
Gaza, Israele, Resistenza e Resa
Gadi Luzzatto Voghera
direttore Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea
Si è concluso nel mese di maggio un lungo percorso didattico condotto con centinaia di studenti e di insegnanti delle scuole secondarie superiori intitolato “Tra Resistenza e Resa. Per (Soprav)Vivere liberi”.
Un titolo ispirato alle parole del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, un teologo che si espresse in maniera esplicita a più riprese contro il nazismo e in difesa della minoranza ebraica. La sua attività lo condusse a collaborare attivamente con la resistenza antinazista fino a subire l’arresto nel 1943, per poi essere accusato di aver partecipato al complotto di von Stauffenberg per uccidere Adolf Hitler. A seguito di questa accusa fu condotto a Flossenburg dove venne sottoposto a un processo farsesco nel quale subì la condanna a morte. Fu impiccato il 9 aprile del 1945, a pochi giorni dalla liberazione. A chi gli chiedeva, in prigionia, come fosse possibile per un teologo rispettare il comandamento “non uccidere” e partecipare al contempo ad atti di resistenza attiva, Bonhoeffer rispondeva: “Se un pazzo guida l’auto sul marciapiede della Kurfürstenstrasse, da pastore non posso solamente seppellire i morti e consolare i parenti: se mi trovo in quel posto io devo fare un salto e strappare l’autista dal volante".
Leggi
I mostri del suprematismo
Moshe Bassano
Il 18 maggio, Benjamin Netanyahu ha annunciato che avrebbe consentito l’ingresso di “una quantità base di cibo” nella Striscia di Gaza. Una decisione che arriva dopo oltre due mesi in cui il suo stesso governo aveva impedito qualunque accesso di aiuti. In un video, Netanyahu ha specificato che questa scelta è stata presa da ragioni “pratiche e diplomatiche”, dopo che anche gli amici di Israele gli avrebbero fatto capire che “erano turbati dalle immagini della popolazione di Gaza ridotta alla fame”.
Come se la distruzione metodica e la sofferenza collettiva della popolazione gazawa negli ultimi mesi non lo avesse già dimostrato, queste parole condensano tutto il cinismo politico dell’attuale leadership israeliana.
Che un capo di governo si esprima in questi termini, purtroppo, non sorprende più di tanto. Anche altri leader autoritari, in passato e nel presente, hanno mostrato lo stesso disprezzo per la vita umana. Ciò che colpisce, però, è che Israele continui a godere di relazioni privilegiate con l’Occidente, Italia inclusa, e sia ancora visto da molti come un baluardo dei “valori europei” e come “l’unica democrazia del Medio Oriente”.
Leggi
Proviamo a fare un giornale
Il lavoro dei giornalisti è sempre più spesso inquadrato e soffocato da iniziative editoriali condizionate. Interessi imprenditoriali e istituzionali mirati a condizionare il mondo dell’informazione si fanno sentire in maniera crescente. Lasciamo spazio ai giornalisti che vorrebbero esprimersi ed esercitare la loro professione in tutta umiltà, ma anche in tutta libertà. Ogni limitazione alla libertà d’opinione deve essere rara, e giustificata dalla preoccupazione di rispettare la legge e le regole di rispetto reciproco. Nessun altro limite può essere tollerato. Perché, oggi più che mai, la libertà d’opinione è minacciata. E il primo dovere di una minoranza è quello di esporsi, di offrire all’intera società la propria visione dei problemi e degli avvenimenti. Le minoranze che si lasciano intimidire, scelgono di tacere o cedono alla tentazione di rintanarsi nella chiusura, si riducono a essere dei semplici gruppi di interesse. Proviamo a fare un giornale.